31-01-2017
La guerra nascosta del Kivu
di Davide Maggiore *

Nel Nord e Sud Kivu è da decenni in atto una guerra nascosta nella quale confluiscono gli interessi di politici e gruppi armati locali, degli Stati limitrofi, di trafficanti di materie prime e di multinazionali, che sfruttano l’instabilità da loro alimentata per saccheggiare le immense risorse della regione
Neanche Natale ha portato la pace nel territorio di Beni, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nella notte della Natività non sono state celebrate le messe – anticipate a prima del tramonto per motivi di sicurezza – ma all'alba del mattino dopo persino questa precauzione si è rivelata inutile per decine di persone. Nei villaggi di Eringeti e Nyanzale i morti in due diversi attacchi sono stati almeno 35, gli ultimi di una lista che, da ottobre 2014, si è allungata fino a comprendere almeno 700 nomi. La stima è delle autorità locali, ma altre fonti citano cifre ancora più alte. L'organizzazione locale Convention pour le respect des droits humains (Crdh) a fine 2016 contava oltre 1.050 vittime, e a ottobre dello stesso anno Fidel Bafilemba, ricercatore indipendente intervistato dall'edizione online di Al-Jazeera, parlava di un numero vicino a 1.300 civili uccisi, generalmente con machete e armi bianche.
“Sono persone che vanno nei campi per procurarsi qualcosa da mangiare e vengono uccise dai miliziani" racconta padre Télesphore Kamberé, sacerdote cattolico che da anni vive nel territorio di Beni, parte della provincia congolese del Nord Kivu. Ma è proprio quando si tratta di identificare questi miliziani che la questione diventa intricata. Il governo locale e quello della capitale Kinshasa attribuiscono la responsabilità alle cosiddette Forze Democratiche Alleate (Adf), gruppo armato nato in Uganda e spostatosi poi in Congo. Una milizia composta prevalentemente da combattenti musulmani, che le autorità congolesi definiscono "jihadisti", parlando anche di legami con realtà internazionali analoghe. Ricostruzioni messe pesantemente in dubbio, però, da più parti. A maggio scorso il gruppo di esperti dell'Onu sulla Repubblica Democratica del Congo ha scritto che non esiste "nessuna prova di queste accuse". D'altro canto, aggiunge padre Telesphore Kamberé, "le Adf non hanno mai rivendicato questi attacchi", come invece fanno praticamente tutti gli altri movimenti armati fondamentalisti, dall'autoproclamato Stato islamico ai nigeriani Boko Haram e agli Shabaab somali. E sempre sul fronte locale, la stessa Crdh, in uno dei suoi ultimi rapporti, è arrivata ad affermare che "il nome Adf è stato manipolato da praticamente tutti i gruppi armati" della zona.
Sono una cinquantina, in effetti, le milizie attive nell'est del Congo: una regione in stato di guerra, a tratti aperta, a tratti latente, da circa vent'anni. Due conflitti internazionali (la prima e la seconda guerra del Congo, tra 1996 e 2003) sono stati solo l'inizio di un eccidio in cui le vittime si sono contate a milioni: almeno 6, secondo una delle stime più condivise. Beni, oggi, è uno dei fronti aperti di questo massacro mai terminato, che però continua a minacciare anche il territorio di Goma, capoluogo del Nord Kivu, ed ha investito ancora in anni recenti anche la provincia confinante, quella del Sud Kivu, con capoluogo Bukavu. Poco hanno fatto contro questo stato di cose, negli anni, le truppe dell'Onu (la cui missione Monusco, oggi, è la più grande al mondo, con circa 23.000 effettivi) e l'esercito nazionale congolese (Fardc). Secondo molti, anzi, proprio le stragi nel territorio di Beni hanno mostrato, una volta di più, la debolezza dei militari. "La situazione ha aggravato la vulnerabilità della regione, la gente fugge perché ha visto la debolezza dell'autorità statale", racconta da Goma Taylor Toeka, giornalista indipendente locale. Che aggiunge poi particolari emblematici sulla brutalità del conflitto: "A volte si spara persino vicino ai centri sanitari e anche i malati devono abbandonare l'ospedale, perché restare non è più possibile". Il risultato della fuga è facile da immaginare: "La povertà cresce, perché la regione dipende dalle attività agricole e dalla pastorizia, ma le persone in fuga non possono né coltivare né allevare".
E proprio la terra è una delle chiavi del conflitto del Kivu: il suolo fertile e il sottosuolo ricco di risorse minerarie (in particolare oro, cassiterite, da cui si ricava lo stagno, e coltan, indispensabile per molti apparecchi elettronici) fanno gola a tanti. Milizie, innanzitutto, ma anche Paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo, in particolare Uganda e Rwanda, considerati ispiratori e finanziatori di molte delle sigle ribelli che si sono succedute negli anni. Ma anche i reparti delle Fardc, in più occasioni, hanno usato metodi identici a quelli delle milizie. Non solo: "Gli uomini politici sono i principali attori del conflitto – continua Taylor Toeka -. Le elezioni non significano niente, quindi si mobilitano i miliziani: quasi ogni gruppo armato ha un sostegno nelle assemblee provinciali, o in Parlamento, o nello stesso governo".
Un quadro intricato, che spinge diverse realtà della società civile congolese, europea e anche statunitense, a chiedere un impegno internazionale più concreto per il Congo. Lo stesso Papa Francesco, nell'Angelus del 15 agosto, aveva parlato di "silenzio vergognoso" sui massacri in Kivu. Ma creare una coscienza civica sul tema, in Occidente, è spesso difficile, come ha sperimentato John Mpaliza. Attivista nato e cresciuto in Congo, ma da anni cittadino italiano, è stato protagonista di varie iniziative di sensibilizzazione. L'ultima, una marcia da Reggio Emilia al Parlamento europeo di Bruxelles, dove ha consegnato una petizione per fermare i massacri di Beni. "Nessuna delle persone che ho incontrato lungo la strada ha cercato di approfondire gli interrogativi che il messaggio del Papa, in qualche caso, aveva suscitato. - racconta –. Persino in Belgio, ex paese colonizzatore e 'capitale' della diaspora congolese, tra la gente comune c'è un'ignoranza dolorosa su quel che sta succedendo".
In questa mancanza di consapevolezza, secondo l'attivista, ha responsabilità anche l'attuale governo congolese. "Il Presidente della repubblica Joseph Kabila e il sistema di potere che gli sta intorno hanno cercato il silenzio su questa situazione. – sostiene -. C'è una correlazione tra la volontà di Kabila di rimanere al potere e quello che avviene all'Est". Il secondo mandato presidenziale del capo dello Stato, in effetti, si è concluso il 19 dicembre scorso. Senza che, però, sia stato eletto un successore. Impossibile organizzare le elezioni, secondo le autorità. Ma l'opposizione ha puntato il dito contro lo stesso Presidente, che secondo la Costituzione non avrebbe potuto ricandidarsi, mentre ora continua a occupare il vertice delle istituzioni. "Più c'è instabilità più Kabila ha l'opportunità di dire che lui non si muoverà" sintetizza anche John Mpaliza. Una mediazione voluta dai Vescovi cattolici ha permesso di arrivare a un'intesa di principio: subito un governo di unità nazionale, poi nuove elezioni, senza la partecipazione di Kabila, entro il 2017. Tempi lunghi, forse necessari ai capi politici di Kinshasa, ma che a 1.500 chilometri di distanza, a Beni e nel Kivu, significano ancora incertezza e paura.
“Sono persone che vanno nei campi per procurarsi qualcosa da mangiare e vengono uccise dai miliziani" racconta padre Télesphore Kamberé, sacerdote cattolico che da anni vive nel territorio di Beni, parte della provincia congolese del Nord Kivu. Ma è proprio quando si tratta di identificare questi miliziani che la questione diventa intricata. Il governo locale e quello della capitale Kinshasa attribuiscono la responsabilità alle cosiddette Forze Democratiche Alleate (Adf), gruppo armato nato in Uganda e spostatosi poi in Congo. Una milizia composta prevalentemente da combattenti musulmani, che le autorità congolesi definiscono "jihadisti", parlando anche di legami con realtà internazionali analoghe. Ricostruzioni messe pesantemente in dubbio, però, da più parti. A maggio scorso il gruppo di esperti dell'Onu sulla Repubblica Democratica del Congo ha scritto che non esiste "nessuna prova di queste accuse". D'altro canto, aggiunge padre Telesphore Kamberé, "le Adf non hanno mai rivendicato questi attacchi", come invece fanno praticamente tutti gli altri movimenti armati fondamentalisti, dall'autoproclamato Stato islamico ai nigeriani Boko Haram e agli Shabaab somali. E sempre sul fronte locale, la stessa Crdh, in uno dei suoi ultimi rapporti, è arrivata ad affermare che "il nome Adf è stato manipolato da praticamente tutti i gruppi armati" della zona.
Sono una cinquantina, in effetti, le milizie attive nell'est del Congo: una regione in stato di guerra, a tratti aperta, a tratti latente, da circa vent'anni. Due conflitti internazionali (la prima e la seconda guerra del Congo, tra 1996 e 2003) sono stati solo l'inizio di un eccidio in cui le vittime si sono contate a milioni: almeno 6, secondo una delle stime più condivise. Beni, oggi, è uno dei fronti aperti di questo massacro mai terminato, che però continua a minacciare anche il territorio di Goma, capoluogo del Nord Kivu, ed ha investito ancora in anni recenti anche la provincia confinante, quella del Sud Kivu, con capoluogo Bukavu. Poco hanno fatto contro questo stato di cose, negli anni, le truppe dell'Onu (la cui missione Monusco, oggi, è la più grande al mondo, con circa 23.000 effettivi) e l'esercito nazionale congolese (Fardc). Secondo molti, anzi, proprio le stragi nel territorio di Beni hanno mostrato, una volta di più, la debolezza dei militari. "La situazione ha aggravato la vulnerabilità della regione, la gente fugge perché ha visto la debolezza dell'autorità statale", racconta da Goma Taylor Toeka, giornalista indipendente locale. Che aggiunge poi particolari emblematici sulla brutalità del conflitto: "A volte si spara persino vicino ai centri sanitari e anche i malati devono abbandonare l'ospedale, perché restare non è più possibile". Il risultato della fuga è facile da immaginare: "La povertà cresce, perché la regione dipende dalle attività agricole e dalla pastorizia, ma le persone in fuga non possono né coltivare né allevare".
E proprio la terra è una delle chiavi del conflitto del Kivu: il suolo fertile e il sottosuolo ricco di risorse minerarie (in particolare oro, cassiterite, da cui si ricava lo stagno, e coltan, indispensabile per molti apparecchi elettronici) fanno gola a tanti. Milizie, innanzitutto, ma anche Paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo, in particolare Uganda e Rwanda, considerati ispiratori e finanziatori di molte delle sigle ribelli che si sono succedute negli anni. Ma anche i reparti delle Fardc, in più occasioni, hanno usato metodi identici a quelli delle milizie. Non solo: "Gli uomini politici sono i principali attori del conflitto – continua Taylor Toeka -. Le elezioni non significano niente, quindi si mobilitano i miliziani: quasi ogni gruppo armato ha un sostegno nelle assemblee provinciali, o in Parlamento, o nello stesso governo".
Un quadro intricato, che spinge diverse realtà della società civile congolese, europea e anche statunitense, a chiedere un impegno internazionale più concreto per il Congo. Lo stesso Papa Francesco, nell'Angelus del 15 agosto, aveva parlato di "silenzio vergognoso" sui massacri in Kivu. Ma creare una coscienza civica sul tema, in Occidente, è spesso difficile, come ha sperimentato John Mpaliza. Attivista nato e cresciuto in Congo, ma da anni cittadino italiano, è stato protagonista di varie iniziative di sensibilizzazione. L'ultima, una marcia da Reggio Emilia al Parlamento europeo di Bruxelles, dove ha consegnato una petizione per fermare i massacri di Beni. "Nessuna delle persone che ho incontrato lungo la strada ha cercato di approfondire gli interrogativi che il messaggio del Papa, in qualche caso, aveva suscitato. - racconta –. Persino in Belgio, ex paese colonizzatore e 'capitale' della diaspora congolese, tra la gente comune c'è un'ignoranza dolorosa su quel che sta succedendo".
In questa mancanza di consapevolezza, secondo l'attivista, ha responsabilità anche l'attuale governo congolese. "Il Presidente della repubblica Joseph Kabila e il sistema di potere che gli sta intorno hanno cercato il silenzio su questa situazione. – sostiene -. C'è una correlazione tra la volontà di Kabila di rimanere al potere e quello che avviene all'Est". Il secondo mandato presidenziale del capo dello Stato, in effetti, si è concluso il 19 dicembre scorso. Senza che, però, sia stato eletto un successore. Impossibile organizzare le elezioni, secondo le autorità. Ma l'opposizione ha puntato il dito contro lo stesso Presidente, che secondo la Costituzione non avrebbe potuto ricandidarsi, mentre ora continua a occupare il vertice delle istituzioni. "Più c'è instabilità più Kabila ha l'opportunità di dire che lui non si muoverà" sintetizza anche John Mpaliza. Una mediazione voluta dai Vescovi cattolici ha permesso di arrivare a un'intesa di principio: subito un governo di unità nazionale, poi nuove elezioni, senza la partecipazione di Kabila, entro il 2017. Tempi lunghi, forse necessari ai capi politici di Kinshasa, ma che a 1.500 chilometri di distanza, a Beni e nel Kivu, significano ancora incertezza e paura.
* nota sull'autore
Giornalista 

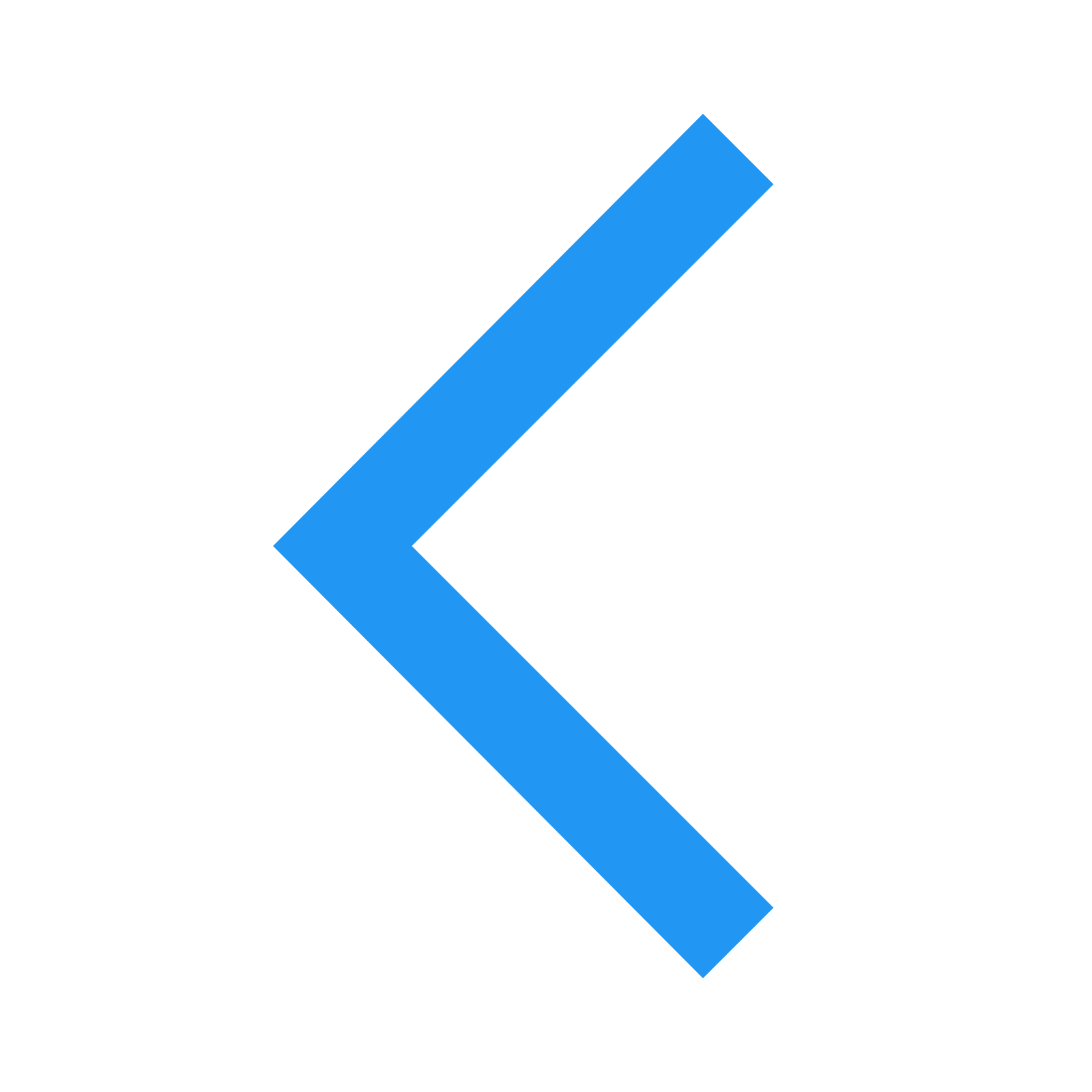 Sommario
Sommario