30-05-2020
Il “Paese degli uomini integri” scosso da conflitti di stampo jihadista
di Chiara De Martino
Nel Nordest del Burkina Faso, da inizio anno, sono almeno cinque gli attacchi registrati contro comunità cristiane. 2000 scuole sono state chiuse. Più di 700 000 sfollati – di tutte le professioni religiose – si contano dal 2012 ad oggi. In una zona sempre più sotto il controllo di gruppi islamisti radicali, si fa tangibile il rischio di un conflitto che si vesta di rivendicazioni religiose. Obiettivo dei gruppi terroristici è creare ostilità utilizzando il pretesto etnico-religioso in una società che è aliena da tensioni di tale natura.
Pansi, villaggio non lontano da Sebba, provincia di Yahgha, nord del Burkina Faso. Il 16 febbraio, i media riportano l’uccisione di 24 persone. Si trattava, secondo le fonti dell’Agenzia Fides, “di un gruppo di paesani di fedi diverse”. Tra questi sembra ci fosse anche un catechista cattolico. Un attacco, l’ennesimo, che ha portato la diocesi di Dori, regione nord del Burkina Faso, alla scelta di chiudere la parrocchia di Sebba. La terza a fermare battente a causa degli attacchi terroristi sempre più frequenti nella zona.
Un centinaio di persone, composte dal clero, dai catechisti e dai loro familiari, sono state fatti evacuare a Dori e alloggiate presso le strutture della Cattedrale. Un numero che si va ad aggiungere agli sfollati dei mesi scorsi dalle due parrocchie già precedentemente chiuse.
Pochi giorni prima, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, un gruppo terrorista (GAT), aveva fatto irruzione a Sebba, attaccando due case. In quell’occasione sei persone erano state rapite, di queste cinque sono state ritrovate poi morte. Si trattava del pastore di una chiesa evangelica, di un diacono, del figlio del pastore e di due dei suoi nipoti.
Domenica 9 febbraio, una chiesa evangelica a Matiakoali, nella regione Est del Burkina Faso secondo NetAfrique, sarebbe stata attaccata da cinque uomini armati. Dal bilancio risultano 2 morti e la chiesa fortemente danneggiata a causa dei numerosi colpi di pistola.
Attacchi frequenti e in crescita
La zona nord ed est del Burkina Faso è ormai quotidianamente presa di mira da gruppi terroristici di stampo islamista. L’attacco del 16 febbraio sarebbe almeno il quinto dall’inizio dell’anno perpetrato ai danni di comunità cristiane. Un dato fortemente in crescita dall’inizio di quest’anno. Dal 2015, gli attacchi jihadisti nel Burkina Faso hanno fatto più di 700 morti, secondo dati dell’AFP (Agence France Presse). E più di 700 000 sfollati all’interno del Paese, secondo le Nazioni Unite.
Dal 2012 l’intera zona del Sahel è diventata base e focolaio di numerosi gruppi jihadisti. Il Sahel, che in arabo significa bordo o riva, proprio come Sahara significa deserto, è – per l’appunto - quella zona africana che si pone subito sotto il deserto del Sahara e che segna la transizione, per clima e per vegetazione, dall’area desertica alle savane, dove le piogge sono frequenti e abbondanti. Si tratta di un’area immensa, che si estende dall’Atlantico all’est al mar Rosso all’ovest. Per un totale di 5km ² e che conta una popolazione di circa 93 milioni di abitanti.
È in questa zona, e più particolarmente in Mauritania, Chad, Niger, Mali e Burkina Faso, che dal 2012 numerosi gruppi jihadisti hanno cominciato a seminare il terrore. L’origine del fenomeno corrisponde, da una parte, alla caduta del generale Muʿammar Gheddafi in Libia e, dall’altra, alla nascita del sedicente Stato Islamico in Iraq.
Nel 2011, 5000 uomini al servizio del governo libico tornano nel Sahel, di cui sono originari. Si tratta anzitutto di popolazioni tuareg che lavorano principalmente come mercenari. Reinsediatisi nelle zone semi-desertiche da cui provengono, al confine tra Sahara a Sahel, cominciano ad operare azioni violente nella regione. Con l’avvento dello Stato Islamico si creano delle collaborazioni tra questi gruppi e le forze terroriste operanti nel Medio-Oriente, a cui i ribelli tuareg si affiliano. Una presenza che diventa ancora più forte con la sconfitta dello Stato Islamico in Siria. Da quel momento, infatti, tutte le forze per l’avvento di uno Stato plasmato secondo il modello della sharia si concentrano nella regione del Sahel, e particolarmente nel Mali.
“Abbiamo avuto l’Afghanistan, non vogliamo un Sahelistan”. E' il 6 luglio 2012. Con queste parole il ministro degli esteri francese, Laurent Fabius, esprime il timore di un nuovo conflitto senza fine contro le forze d’Islam radicale stabilitesi nel Sahel. Il 6 aprile dello stesso anno i ribelli tuareg del Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad (MNLA), assieme al movimento salafita Ansar Dine, alleato degli islamisti, dichiarano l’indipendenza di un territorio corrispondente alla parte nord del Mali e puntano alla presa della capitale, Bamako. L’obiettivo è quello di instaurare una repubblica islamica, con l’applicazione della sharia.
Il 15 aprile l’operazione Serval è lanciata dall’allora presidente francese François Hollande. Con lo scopo di fermare le forze jihadiste che avanzano verso Bamako, e permettere al governo maliano di riappropriarsi dei territori occupati. Da agosto 2014, raggiunti gli obiettivi sperati, e sventato il rischio di una presa della capitale, Serval viene sostituita dall’operazione Barkhane. In questo caso l’obiettivo è più ampio. Rivolta alle cinque ex-colonie subsahariane francesi (Mali, Chad, Burkina Faso, Mauritania e Niger), Barkhane, che significa ‘duna’ in linguaggio tuareg, intende debellare la minaccia islamista a più ampio raggio, in collaborazione con le forze armate delle zone colpite.
Ad oggi, se gli sforzi direzionati verso il Mali hanno ottenuto dei risultati, la minaccia continua a essere presente nell’area. Col tempo, le forze jihadiste sono, però, emigrate verso il nord-est del Burkina Faso.
La zona rossa: un terreno “favorevole”
Come osserva un’analisi dell’International Crisis Group, dal titolo "Le origini sociali della violenza jihadista nel nord del Brukina Faso", e come si afferma in diversi altri studi, le forze estremiste stabilitesi nel Shael burkinabé e nell’est del paese, la cui capitale regionale è Fada N’gourma, hanno potuto facilmente innestarsi nel territorio facendo leva sul sentimento di marginalizzazione politica ed economica presente nell’area. Soprannominata la “zona rossa” per la forte attività criminale, il Sahel è un’area di contrabbando cruciale per l’economia locale. Sigarette, carburante, avorio, armi, stupefacenti e beni di consumo vari attraversano l’area ogni giorno. La regione est permette, infatti, di accedere alle coste di Benin, Ghana e Togo. Alla forte illegalità del territorio, si aggiunge la mancanza di investimenti pubblici, un bassissimo accesso ad acqua ed elettricità, così come una scarsa scolarizzazione. Solamente il 10% dei capi famiglia ha avuto un’educazione superiore alla scuola primaria di primo grado, e più del 60% non ha mai avuto accesso all’istruzione.
Le forze jihadiste hanno approfittato di questa situazione di fragilità endogena per impiantarsi stabilmente nella regione. Come messo in evidenza dall’analista Tanguy Quidelleur - esperto dei conflitti nella regione - nell’articolo "Le radici locali della violenza nell’est del Burkina Faso", pubblicato dal Centro di ricerca indipendente "Noria", “l’apparizione del fenomeno jihadista non costituisce una novità per il suo utilizzo delle armi. Ma, prendendo di mira lo Stato e i suoi simboli, crea una rottura col sistema di violenza fino ad allora esistente, che si limitava al controllo delle attività criminali e del territorio, anche in legame con il potere centrale”. Le forze jihadiste, infatti, facendosi portatrici delle rivendicazioni della popolazione locale in chiave islamista, si propongono come totale alternativa al potere centrale. Questo permette di reclutare, osserva Quidelleur, combattenti locali: "All’interno del gruppo si trovano dei rappresentanti di tutte le comunità regionali”.
ONU: il numero di sfollati è aumentato di 12 volte rispetto allo scorso anno
Ad oggi si contano 765 000 sfollati nel Burkina Faso. Secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, il loro numero è aumentato di 16 volte rispetto a gennaio 2019. Dal primo gennaio, 4000 persone sfuggono quotidianamente dai loro villaggi a causa delle minacce jihadiste locali. 2000 scuole hanno dovuto chiudere. E circa 300 000 studenti sono impossibilitati ad andare a studiare.
Inoltre, come indicato in un reportage realizzato il 24 aprile da "France 24", in seguito alla propagazione del Coronavirus nel continente africano, dei primi casi di infezione sono stati rilevati nella zona di Pissila, nel Centro-Nord del paese, dove si situa anche il principale campo profughi del Burkina. Un numero che rischia di crescere, aggiungendo un’ulteriore problematica in un contesto già delicato.
In questa fragile situazione, già dichiarata “emergenza umanitaria senza precedenti per il Burkina Faso” dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), il governo centrale rifiuta di riconoscere l’origine interna del problema.
Il rischio di un conflitto interconfessionale
Gli attacchi a chiese e fedeli si inscrivono, dunque, all’interno di un fenomeno ben più vasto, e non necessariamente religioso. In questo contesto, però, la questione religiosa rischia di essere utilizzata come simbolo e strumento di lotta, per avanzare le rivendicazioni contro lo Stato centrale. In un’area dove i cristiani sono una piccolissima minoranza, rispetto alla maggioranza musulmana, la tradizionale tolleranza religiosa è stata soppiantata da un crescendo di violenze, che usano lo strumento della rivendicazione identitaria di stampo islamista per affermare se stesse.
Già lo scorso luglio monsignor Laurent Birfuoré Dabiré, vescovo della diocesi di Dori, in una intervista a Vatican News ha rilevato che la situazione d’insicurezza nel nord-est del Burkina Faso era sempre più evidente. “Dal 2015 assistiamo a degli attacchi ripetuti, che hanno avuto inizio con delle aggressioni contro le forze militari, poi si sono dirette alle autorità amministrative e religiose, adesso alla popolazione civile. In particolar modo contro la comunità cattolica e quella protestante". Nell'intervista il vescovo di Dori ricordava come queste tensioni avessero condotto al rapimento di un prete della sua diocesi il 17 marzo dello stesso anno, e alla morte di un sacerdote della diocesi vicina. “È una situazione che si degrada progressivamente e che rende inquieta la popolazione, costretta a fuggire. La società rischia di frantumarsi, se le crisi e i conflitti intercomunitari continueranno ad aumentare di peso”. L’obiettivo dei capifila dei gruppi terroristici è, a suo avviso, creare un conflitto utilizzando il pretesto etnico e religioso in una società che – di per sé – è aliena da tensioni di tale natura.
Un centinaio di persone, composte dal clero, dai catechisti e dai loro familiari, sono state fatti evacuare a Dori e alloggiate presso le strutture della Cattedrale. Un numero che si va ad aggiungere agli sfollati dei mesi scorsi dalle due parrocchie già precedentemente chiuse.
Pochi giorni prima, nella notte tra il 10 e l’11 febbraio, un gruppo terrorista (GAT), aveva fatto irruzione a Sebba, attaccando due case. In quell’occasione sei persone erano state rapite, di queste cinque sono state ritrovate poi morte. Si trattava del pastore di una chiesa evangelica, di un diacono, del figlio del pastore e di due dei suoi nipoti.
Domenica 9 febbraio, una chiesa evangelica a Matiakoali, nella regione Est del Burkina Faso secondo NetAfrique, sarebbe stata attaccata da cinque uomini armati. Dal bilancio risultano 2 morti e la chiesa fortemente danneggiata a causa dei numerosi colpi di pistola.
Attacchi frequenti e in crescita
La zona nord ed est del Burkina Faso è ormai quotidianamente presa di mira da gruppi terroristici di stampo islamista. L’attacco del 16 febbraio sarebbe almeno il quinto dall’inizio dell’anno perpetrato ai danni di comunità cristiane. Un dato fortemente in crescita dall’inizio di quest’anno. Dal 2015, gli attacchi jihadisti nel Burkina Faso hanno fatto più di 700 morti, secondo dati dell’AFP (Agence France Presse). E più di 700 000 sfollati all’interno del Paese, secondo le Nazioni Unite.
Dal 2012 l’intera zona del Sahel è diventata base e focolaio di numerosi gruppi jihadisti. Il Sahel, che in arabo significa bordo o riva, proprio come Sahara significa deserto, è – per l’appunto - quella zona africana che si pone subito sotto il deserto del Sahara e che segna la transizione, per clima e per vegetazione, dall’area desertica alle savane, dove le piogge sono frequenti e abbondanti. Si tratta di un’area immensa, che si estende dall’Atlantico all’est al mar Rosso all’ovest. Per un totale di 5km ² e che conta una popolazione di circa 93 milioni di abitanti.
È in questa zona, e più particolarmente in Mauritania, Chad, Niger, Mali e Burkina Faso, che dal 2012 numerosi gruppi jihadisti hanno cominciato a seminare il terrore. L’origine del fenomeno corrisponde, da una parte, alla caduta del generale Muʿammar Gheddafi in Libia e, dall’altra, alla nascita del sedicente Stato Islamico in Iraq.
Nel 2011, 5000 uomini al servizio del governo libico tornano nel Sahel, di cui sono originari. Si tratta anzitutto di popolazioni tuareg che lavorano principalmente come mercenari. Reinsediatisi nelle zone semi-desertiche da cui provengono, al confine tra Sahara a Sahel, cominciano ad operare azioni violente nella regione. Con l’avvento dello Stato Islamico si creano delle collaborazioni tra questi gruppi e le forze terroriste operanti nel Medio-Oriente, a cui i ribelli tuareg si affiliano. Una presenza che diventa ancora più forte con la sconfitta dello Stato Islamico in Siria. Da quel momento, infatti, tutte le forze per l’avvento di uno Stato plasmato secondo il modello della sharia si concentrano nella regione del Sahel, e particolarmente nel Mali.
“Abbiamo avuto l’Afghanistan, non vogliamo un Sahelistan”. E' il 6 luglio 2012. Con queste parole il ministro degli esteri francese, Laurent Fabius, esprime il timore di un nuovo conflitto senza fine contro le forze d’Islam radicale stabilitesi nel Sahel. Il 6 aprile dello stesso anno i ribelli tuareg del Movimento nazionale per la liberazione dell’Azawad (MNLA), assieme al movimento salafita Ansar Dine, alleato degli islamisti, dichiarano l’indipendenza di un territorio corrispondente alla parte nord del Mali e puntano alla presa della capitale, Bamako. L’obiettivo è quello di instaurare una repubblica islamica, con l’applicazione della sharia.
Il 15 aprile l’operazione Serval è lanciata dall’allora presidente francese François Hollande. Con lo scopo di fermare le forze jihadiste che avanzano verso Bamako, e permettere al governo maliano di riappropriarsi dei territori occupati. Da agosto 2014, raggiunti gli obiettivi sperati, e sventato il rischio di una presa della capitale, Serval viene sostituita dall’operazione Barkhane. In questo caso l’obiettivo è più ampio. Rivolta alle cinque ex-colonie subsahariane francesi (Mali, Chad, Burkina Faso, Mauritania e Niger), Barkhane, che significa ‘duna’ in linguaggio tuareg, intende debellare la minaccia islamista a più ampio raggio, in collaborazione con le forze armate delle zone colpite.
Ad oggi, se gli sforzi direzionati verso il Mali hanno ottenuto dei risultati, la minaccia continua a essere presente nell’area. Col tempo, le forze jihadiste sono, però, emigrate verso il nord-est del Burkina Faso.
La zona rossa: un terreno “favorevole”
Come osserva un’analisi dell’International Crisis Group, dal titolo "Le origini sociali della violenza jihadista nel nord del Brukina Faso", e come si afferma in diversi altri studi, le forze estremiste stabilitesi nel Shael burkinabé e nell’est del paese, la cui capitale regionale è Fada N’gourma, hanno potuto facilmente innestarsi nel territorio facendo leva sul sentimento di marginalizzazione politica ed economica presente nell’area. Soprannominata la “zona rossa” per la forte attività criminale, il Sahel è un’area di contrabbando cruciale per l’economia locale. Sigarette, carburante, avorio, armi, stupefacenti e beni di consumo vari attraversano l’area ogni giorno. La regione est permette, infatti, di accedere alle coste di Benin, Ghana e Togo. Alla forte illegalità del territorio, si aggiunge la mancanza di investimenti pubblici, un bassissimo accesso ad acqua ed elettricità, così come una scarsa scolarizzazione. Solamente il 10% dei capi famiglia ha avuto un’educazione superiore alla scuola primaria di primo grado, e più del 60% non ha mai avuto accesso all’istruzione.
Le forze jihadiste hanno approfittato di questa situazione di fragilità endogena per impiantarsi stabilmente nella regione. Come messo in evidenza dall’analista Tanguy Quidelleur - esperto dei conflitti nella regione - nell’articolo "Le radici locali della violenza nell’est del Burkina Faso", pubblicato dal Centro di ricerca indipendente "Noria", “l’apparizione del fenomeno jihadista non costituisce una novità per il suo utilizzo delle armi. Ma, prendendo di mira lo Stato e i suoi simboli, crea una rottura col sistema di violenza fino ad allora esistente, che si limitava al controllo delle attività criminali e del territorio, anche in legame con il potere centrale”. Le forze jihadiste, infatti, facendosi portatrici delle rivendicazioni della popolazione locale in chiave islamista, si propongono come totale alternativa al potere centrale. Questo permette di reclutare, osserva Quidelleur, combattenti locali: "All’interno del gruppo si trovano dei rappresentanti di tutte le comunità regionali”.
ONU: il numero di sfollati è aumentato di 12 volte rispetto allo scorso anno
Ad oggi si contano 765 000 sfollati nel Burkina Faso. Secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, il loro numero è aumentato di 16 volte rispetto a gennaio 2019. Dal primo gennaio, 4000 persone sfuggono quotidianamente dai loro villaggi a causa delle minacce jihadiste locali. 2000 scuole hanno dovuto chiudere. E circa 300 000 studenti sono impossibilitati ad andare a studiare.
Inoltre, come indicato in un reportage realizzato il 24 aprile da "France 24", in seguito alla propagazione del Coronavirus nel continente africano, dei primi casi di infezione sono stati rilevati nella zona di Pissila, nel Centro-Nord del paese, dove si situa anche il principale campo profughi del Burkina. Un numero che rischia di crescere, aggiungendo un’ulteriore problematica in un contesto già delicato.
In questa fragile situazione, già dichiarata “emergenza umanitaria senza precedenti per il Burkina Faso” dall’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA), il governo centrale rifiuta di riconoscere l’origine interna del problema.
Il rischio di un conflitto interconfessionale
Gli attacchi a chiese e fedeli si inscrivono, dunque, all’interno di un fenomeno ben più vasto, e non necessariamente religioso. In questo contesto, però, la questione religiosa rischia di essere utilizzata come simbolo e strumento di lotta, per avanzare le rivendicazioni contro lo Stato centrale. In un’area dove i cristiani sono una piccolissima minoranza, rispetto alla maggioranza musulmana, la tradizionale tolleranza religiosa è stata soppiantata da un crescendo di violenze, che usano lo strumento della rivendicazione identitaria di stampo islamista per affermare se stesse.
Già lo scorso luglio monsignor Laurent Birfuoré Dabiré, vescovo della diocesi di Dori, in una intervista a Vatican News ha rilevato che la situazione d’insicurezza nel nord-est del Burkina Faso era sempre più evidente. “Dal 2015 assistiamo a degli attacchi ripetuti, che hanno avuto inizio con delle aggressioni contro le forze militari, poi si sono dirette alle autorità amministrative e religiose, adesso alla popolazione civile. In particolar modo contro la comunità cattolica e quella protestante". Nell'intervista il vescovo di Dori ricordava come queste tensioni avessero condotto al rapimento di un prete della sua diocesi il 17 marzo dello stesso anno, e alla morte di un sacerdote della diocesi vicina. “È una situazione che si degrada progressivamente e che rende inquieta la popolazione, costretta a fuggire. La società rischia di frantumarsi, se le crisi e i conflitti intercomunitari continueranno ad aumentare di peso”. L’obiettivo dei capifila dei gruppi terroristici è, a suo avviso, creare un conflitto utilizzando il pretesto etnico e religioso in una società che – di per sé – è aliena da tensioni di tale natura.


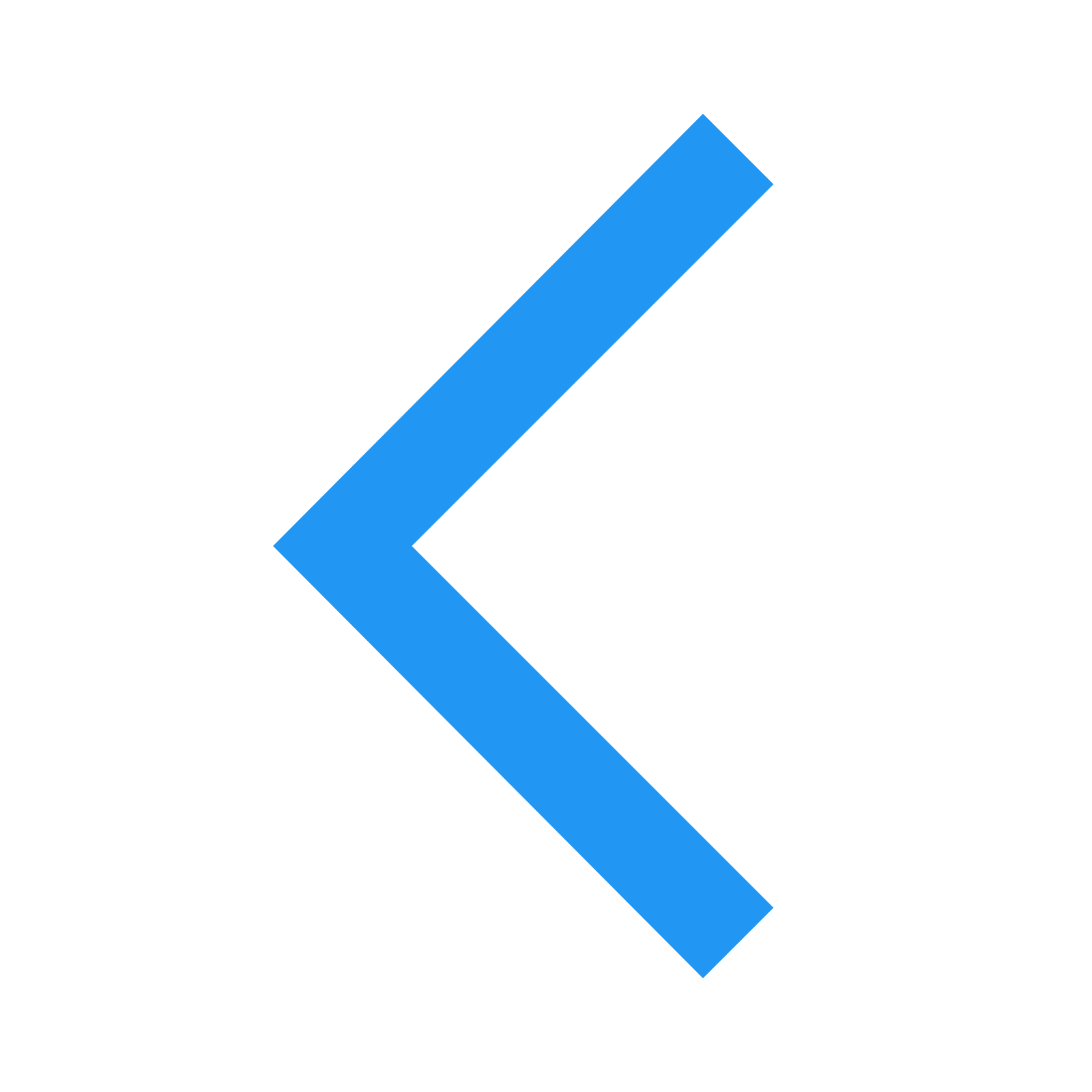 Sommario
Sommario